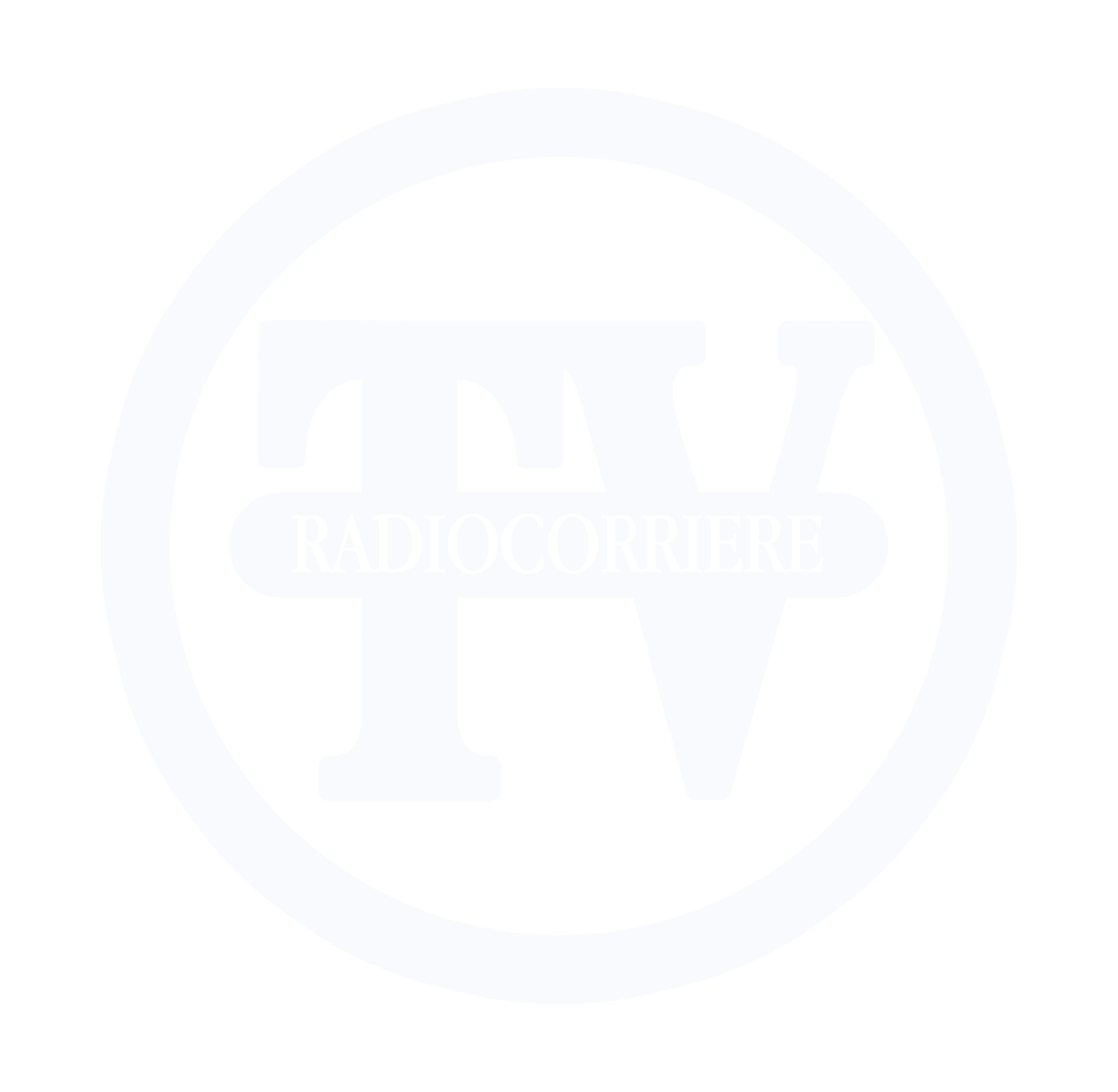Quella chimica perfetta
GIOVANNI LUDENO

«Il teatro è per me quel luogo magico pieno di mistero, in cui uno inizia a fare i primi giochi con la rappresentazione, con l’amore che ha per le storie e per i personaggi» racconta l’attore napoletano, tra i protagonisti fin dalla prima stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”. Il lunedì in prima serata su Rai 1
Un grande successo che si rinnova. Cos’ha di speciale questo progetto?
Sono storie molto appassionate, la serie non si limita al poliziesco, non è solo un giallo ma, con il pretesto del crime, approfondisce il mondo dei suoi personaggi. È una cosa che mi ha colpito subito, la presenza di una grande famiglia che si ritrova attorno al mondo della protagonista, una vicequestore che si trascina dietro tantissime piccole ferite. Ciascuno dei personaggi è, dunque, intento a risolvere le piccole imperfezioni della propria struttura umana e sentimentale.
È un po’ come se Lolita, una donna così empatica, costringesse tutti allo step successivo…
Forte e Lobosco sono speculari, sono legati fin da ragazzi e si ritrovano con il ritorno di Lolita a Bari. I due sono stati compagni di scuola, alle elementari e alle scuole medie, c’è stata poi la formazione adolescenziale, l’università, fino a quando poi, nel passaggio alla vita adulta, lei ha fatto scelte diverse e si sono allontanati…
Il vantaggio della serialità è quello di approfondire meglio i personaggi. Com’è cresciuto il suo?
Il ringraziamento più grande va ovviamente a Gabriella Genisi e ai suoi romanzi sui quali sono intervenuti con maestria e amore gli sceneggiatori che da quelle pagine hanno tirato fuori i personaggi, rendendo ancora più appassionanti le loro vite. A fare tutto il resto c’è il passaggio alla regia, al direttore artistico, fino ad arrivare alla recita con noi attori che abbiamo dato carne, nervi, sentimenti, emozioni. C’è una famosa intervista della tv americana a Sophia Loren e Marcello Mastroianni in cui i due artisti non seppero rispondere alla domanda sul perché facessero tutti i film insieme. Non ci sono parole per spiegare questo, è “solo” una questione di chimica. È lo stesso che è successo ai personaggi di Antonio e Lolita, al mondo che questa donna porta con sé, a quei legami che, di anno in anno, sono cresciuti sempre di più. Una chimica che parte dal set e che di stagione in stagione si è amplificata.
E quando questa chimica dovesse venire a mancare?
Subentra il mestiere. Credo, però, che il successo della serie sia da ritrovare in quel qualcosa in più che il pubblico percepisce. C’è poi la protagonista, Luisa Ranieri, oltre a essere una grande attrice, e non lo scopriamo certamente con “Le indagini di Lolita Lobosco”, è in uno stato di grazia totale. Questa ultima stagione lo conferma. Uno stato di grazia incosciente, ovviamente, perché la grazia non è qualcosa che si decide, arriva e basta. Mi viene in mente il Dolce stil novo con l’immagine della donna che illuminava tutto quello che incontrava: “Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quand’ella altrui saluta”. Il rischio di una terza stagione poteva essere la fiacca, non era scontato che quello che aveva funzionato prima potesse riuscire anche nel nuovo capitolo. La chimica è, invece, raddoppiata, tutti abbiamo dato il massimo, passando sempre la palla al nostro Maradona.
Napoletano come Luisa Ranieri, calati però in una Bari piena di luce…
…e però appena chiamavano lo stop ritornavamo immediatamente due napoletani (ride). Abbiamo dovuto tenere a bada la nostra natura, ma era anche una sorta di deterrente. I nostri personaggi sappiamo che hanno dei precedenti di conoscenza, non c’è un prequel che lo racconta, io e Lolita abbiamo così trovato il nostro minimo comune denominatore nella lingua napoletana. Una musicalità, una identità partenopea, una base comune che ci ha aiutato a trovare subito un’intesa.
Essere napoletano è come “nascere” attore nella recita della vita?
Diciamo che si è un po’ condannati da questa spada di Damocle: o rubi i portafogli o fai l’attore. Da bambino frequentavo le colonie dei ferrovieri, il pregiudizio sui napoletani era evidente. Quando si è piccoli, si cresce con i luoghi comuni, credi a quello che ti viene raccontato, diventa la tua verità. Noi bimbi partenopei ispiravamo anche molta simpatia, a me costringevano a recitare, anche se io ero molto timido. Era un po’ scritto quello che avrei fatto nella vita.
Con il successo di “Lolita Lobosco” cresce anche la fama. Che rapporto ha con la gente, con i fan?
Ci sono il bello e il brutto, come tutte le cose. A volte ti considerano come un loro parente, uno di casa, ma tu non le conosci queste persone, potrebbe crearsi qualche imbarazzo, mai fastidio però. Di contro, sapere che la gente prova affetto per te, per quello che fai, è molto carino. Non ce la passiamo molto bene di questi tempi, le persone necessitano di leggerezza, e la trovano anche nelle nostre storie, trovano conforto nel fatto che i nostri personaggi non rappresentano modelli di perfezione, sono incompleti, hanno mille problemi come tutti. Oggi sentirsi completi, a posto, è faticosissimo, le generazioni precedenti basavano la loro identità, la loro ricchezza morale, su dei principi culturali, politici ed economici molto più stabili e solidi dei nostri. Il lavoro lo trovavi quasi subito, riuscivi a creare una famiglia, ad accedere al mutuo, compravi gli elettrodomestici… c’era una maggiore sicurezza. Oggi per noi è tutto più traballante. In “Lolita Lobosco” pur mantenendo solarità e un forte senso dell’humor, i protagonisti vivono la difficoltà, si mettono costantemente in discussione.
E questo favorisce il gioco dell’immedesimazione…
Il pubblico vorrebbe compiere le azioni del personaggio, essere quel personaggio e magari arrivare alla famosa catarsi per purificarsi, per sentirsi liberi. È il grande insegnamento del teatro greco, il pubblico si immedesimava nelle storie, anche abbastanza cruente, per trovare pace. È quello che accade anche ora, con queste piccole storie che si raccontano la sera in televisione. Il processo è il medesimo.
Nel suo curriculum c’è tanto teatro. Cosa rappresenta per lei?
È qualcosa di molto viscerale, un cordone ombelicale mai tagliato. Mi sono formato a teatro, è vero, ma non amo definirmi un attore di teatro, un attore lo è sempre, a prescindere dal palco su cui ti esibisci. Ma questa è una questione molto italiana. Il teatro è per me è quel luogo magico pieno di mistero, in cui uno inizia a fare i primi giochi con la rappresentazione, con l’amore che ha per le storie e per i personaggi. Questo sentimento lo provi e poi lo liberi nell’incontro con il pubblico, nelle serate dal vivo.
Molti attori, in particolare chi ha cominciato molto giovane e “per caso”, al teatro ritorna…
Diciamo che in questo mestiere c’è una percentuale di caso, quando la casualità non rappresenta qualcosa di buono non aiuta a mettere bene a fuoco anche il proprio talento. Io non so se sono veramente contrario al caso, quello che ti catapulta in questo mondo e, all’improvviso, ti fa diventare una star. “Sarà la storia a giudicare”, disse Fidel Castro all’Onu. Va bene anche per un attore. Quello che, alla fine, conta nel nostro mestiere è la resistenza, la pazienza, quanto sei disposto a mettere in gioco di te stesso. È un lavoro faticoso nel quale si è sempre in ballo, non è mai concesso staccare la spina. Ma questo è anche la sua bellezza, ogni volta sei trascinato dentro nella totalità del tuo essere. Ci sono certamente tecniche che aiutano ad arrivare prima agli obiettivi, più le tecniche, prima riesci a sfondare altre porte.
Come sono cambiate nel tempo le sue ambizioni da attore?
Io sono un uomo totalmente privo di ambizione, mi manca anche quella positiva, che stimola, faccio più che altro affidamento a quella tensione continua che mi spinge a migliorarmi, nella vita e nel lavoro. È una ricerca al vivere meglio, non da solo però, perché la condizione imprescindibile dell’essere umano, e quindi anche dell’artista, è il confrontarsi con una comunità, con il mondo. Un solipsista non avrebbe senso. Tutta l’ispirazione, tutta l’arte, il film che si sceglie di fare, il romanzo che si sceglie di scrivere, il personaggio che si sceglie di interpretare, in un modo piuttosto che un altro… la recitazione è un grande mistero. Potrei dire che l’ambizione vive nello scegliere ogni volta quale strada voglio percorrere, non certo per portare a casa trofei, non mi è mai interessato. Alla fine, le cose vengono, il pubblico, se fai bene, ti segue. Essere amati è magico, soprattutto in questi tempi in cui se ti esponi, qualunque mestiere tu faccia, vieni fatto a pezzi. Si è sempre soggetti al giudizio altrui, da artista devi avere la forza a non farti logorare dalle critiche, anche quelle feroci e amplificate dai social media, dove chiunque si sente autorizzato a sentenziare.
Come reagisce alle critiche?
Non mi possono arrivare, perché il peggiore critico di me stesso sono io, sono molto più “criminale” dell’ultimo hater nascosto nei social. Ho una cattiveria molto profonda verso me stesso, per questo pago fior fiore di analisti (ride). Non mi ferisce se qualcuno prova a insultarmi dicendomi che sono troppo calvo.
Prossimi step del suo lavoro?
Si è da poco conclusa la mia partecipazione nella seconda stagione di “Vincenzo Malinconico. Avvocato di insuccesso”, e ora mi dedico al teatro, con degli amici musicisti organizziamo delle serate molto improvvisate tra letteratura e musica. Lo spettacolo, per ora solo a Napoli, si chiama “Che’ succies”, una frase che fa riferimento alla battuta di Amalia che precede quella più famosa pronunciata da Gennaro Jovine in “Napoli milionaria”. Tutti ricordano “Ha da passa’ a nuttata”, un po’ il marchio di Napoli. Se De Filippo avesse chiuso prima la commedia, forse la napoletanità avrebbe fatto tutt’altro corso. È la teoria su cui ci concentriamo durante tutta la serata.