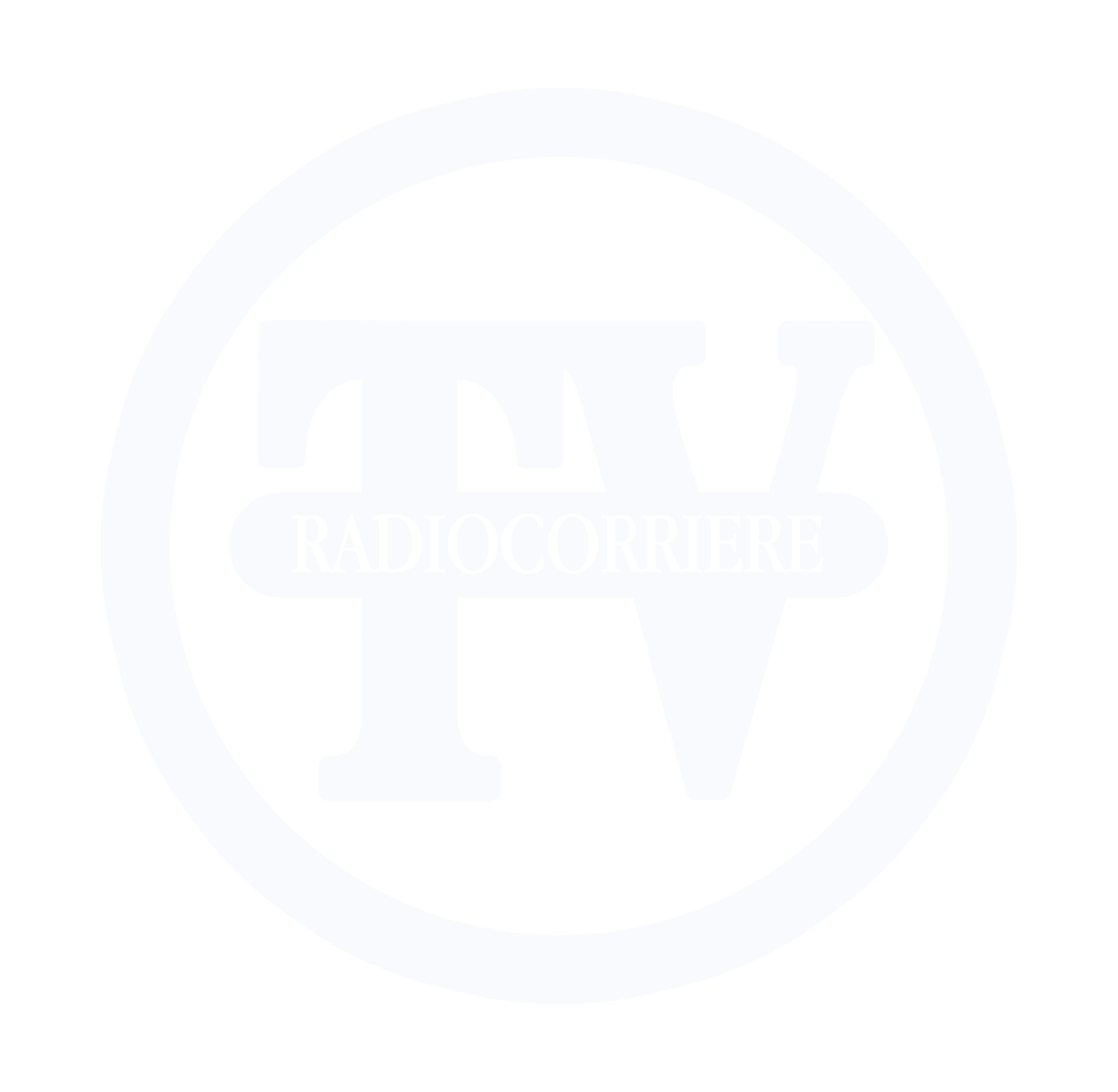Il Commissario Montalbano torna in Tv
Rai trasmetterà in prima serata Rai 1, da martedì 9 settembre, una selezione di 15 episodi della serie, un viaggio nella memoria, un’immersione profonda tra i paesaggi di Vigata, i delitti da risolvere e le atmosfere inconfondibili che hanno reso Montalbano la serie di maggior successo del piccolo schermo italiano.
- Il ladro di merendine
- La voce del violino
- La forma dell’acqua
- Il cane di terracotta
- La gita a Tindari
- Tocco d’artista
- Il senso del tatto
- Gli arancini di Montalbano
- L’odore della notte
- Gatto e cardellino
- Il giro di boa
- Par condicio
- La pazienza del ragno
- Il gioco delle tre carte
- La vampa d’agosto
- Le ali della sfinge
- La pista di sabbia
- La luna di carta
- Il campo del vasaio
- La danza del gabbiano
- La caccia al tesoro
- L’età del dubbio
- Il sorriso di Angelica
- Il gioco degli specchi
- Una voce di notte
- Una lama di luce
- Una faccenda delicata
- La piramide di fango
- Un covo di vipere
- Come voleva la prassi
- La giostra degli scambi
- Amore
- L’altro capo del filo
- Un diario del ’43
- Salvo amato, Livia mia
- La rete di protezione
- Il metodo Catalonotti
——
Il mio “amore-odio” per il Commissario
“Montalbano, per me, dopo vent’anni è un parente al quale voglio bene, ma nello stesso tempo è un personaggio scomodo. Perché il suo successo trascinava al successo anche gli altri romanzi, i miei romanzi storici, i miei romanzi civili. Quindi, lo odio e lo amo”
Andrea Camilleri
“All’inizio non avevo affatto l’intenzione di fare del Commissario Montalbano un personaggio seriale, avevo cominciato a scrivere esclusivamente per me, come esercizio di scrittura: un romanzo con una sua struttura, un primo capitolo, e poi una successione temporale, spaziale… Il problema fu che i primi due romanzi ebbero un grande successo e, in un certo senso, mi sentii quasi costretto a scriverne degli altri. Il rischio, con un personaggio seriale, era però la ripetitività, era necessario stare molto attenti a variare, di romanzo in romanzo, le situazioni, i toni, le modalità narrative”. Così Camilleri racconta la genesi dei romanzi dedicati al commissario (tutti pubblicati da Sellerio), convinto del fatto che i personaggi “fissi”, come per esempio quelli che compongono il commissariato, se ben disegnati, avrebbero certamente creato un legame con il pubblico. La scommessa più grande era capire se un personaggio come Catarella sarebbe riuscito a generare lo stesso tipo di empatia: “Devo confessare che Catarella non è un’invenzione totale. Io, come lui, ho sentito parlare tante persone, oggi molto meno, anche grazie alla televisione, che ha insegnato a molti italiani a parlare in modo più corretto. Ma un tempo, un povero contadino che non sapeva l’italiano cercava di parlarlo così, a modo suo. I pupari, quelli che facevano il teatro dei pupi, recitavano in questo modo: una combinazione assurda di parole siciliane e italiane deformate, convinti di parlare una lingua elegante. Ecco, Catarella è questo. Molti tratti del personaggio li ho presi, per esempio, da un attendente di mio padre, che parlava esattamente come lui. Altri aspetti li ho inventati. Ma l’essenziale era centrare certi modi di dire ricorrenti, come il celebre “di persona, personalmente”, espressioni che trasformano Catarella da semplice personaggio in una vera e propria maschera. Non volevo farne una macchietta, bensì una maschera — e in Sicilia di maschere ne abbiamo appena due o tre”. Per quanto riguarda le sceneggiature della serie, confessa di aver sempre rimesso mano ai dialoghi, esattamente come faceva Eduardo De Filippo, che sul copione, prima di iniziare le prove, apportava modifiche scegliendo la parola napoletana che, per assonanza, fosse più vicina all’italiano. Quando gli chiedeva: «Ma così si perde forza», lui rispondeva: «Pazienza, Camilleri. Così la capiscono anche a Voghera». E il maestro ha fatto lo stesso, consapevolmente: sostituire alcune espressioni per rendere i dialoghi più comprensibili, evitare il brutto siciliano recitato da chi siciliano non è, facilitare la comprensione: “Nei romanzi di Montalbano c’era già l’enigma poliziesco: non era necessario imporre allo spettatore un secondo enigma, quello di capire cosa viene detto — soprattutto in televisione, dove ciò che si dice non viene ripetuto”.
Il primo romanzo di Camilleri dedicato al Commissario risale al 1994, “La forma dell’acqua”. Appare per la prima volta Salvo Montalbano (nome in omaggio al giallista spagnolo Manuel Vazquez Montalban), un uomo e un poliziotto dotato di grande acume e di una pietas fuori dal comune che gli permette di comprendere bene le miserie umane. Ma anche un personaggio che affascina per i suoi modi investigativi piuttosto spicci, la meteoropatia, l’amore per la buona tavola, i libri e le donne complicate. Per il Maestro fu sempre amore e odio perché, una volta acquisita la capacità di vivere di vita propria, grazie anche al successo televisivo, costringe l’autore a un eterno inseguimento.
“Scrivo perché non so fare altro. Scrivo perché così mi ricordo di tutte le persone che ho amato. Scrivo per restituire qualcosa di tutto quello che ho letto. Scrivo perché mi piace raccontarmi storie”
Le storie, quelle che ci hanno trasportato per un ventennio e ben 37 episodi (il primo a maggio del 1999 su Rai 2, l’ultimo a marzo 2021 con “Il metodo Catalanotti) in una Sicilia immaginaria, bellissima e vera raccontata, nei libri e in tv, da una lingua che mescola parole, dialetti e riferimenti letterari, una sorta di partitura di suoni che nasconde la fatica della costruzione e lascia libera la gioia del narrare: “Il passaggio c’è stato nel momento in cui ho deciso che mi ero stufato di raccontare in teatro storie d’altri, con parole d’altri. E per raccontare la storia mia, dovevo trovare un mio modo di scrivere. Un mio modo di scrivere che rispettasse sempre e comunque la struttura dell’italiano… Il lavoro dialettale è successivo, ma non si tratta di incastonare parole in dialetto all’interno di frasi strutturalmente italiane, quanto piuttosto di seguire il flusso di un suono, componendo una sorta di partitura che invece delle note adopera il suono delle parole.” E così, da quella prima volta i cui abbiamo sentito pronunciare “Montalbano sono”, il personaggio letterario si è fatto “carne e ossa” con Luca Zingaretti (che ha diretto alcuni episodi dopo la morte di Alberto Sironi, regista storico), trascinando lo spettatore nelle atmosfere barocche della Sicilia di Camilleri. “Di persona personalmente”, come avrebbe detto Catarella, il commissario si è fatto “carne e ossa” con Luca Zingaretti.