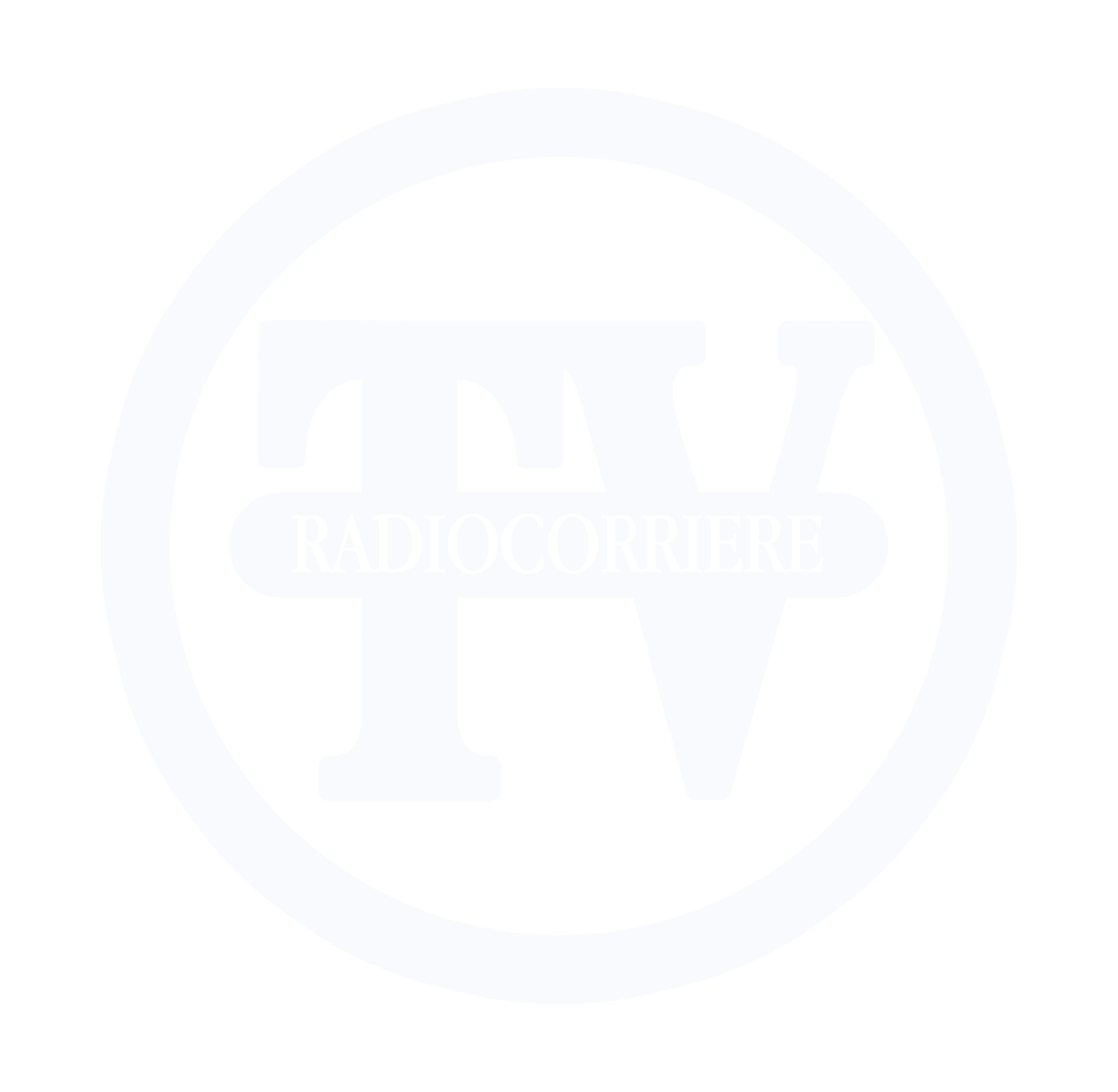“Il mio sicitalianese”
«Quello del dialetto è un problema antichissimo, che affonda le radici nell’Unità d’Italia. Abbiamo rischiato grosso con il fascismo, che abolì del tutto i dialetti in favore della lingua italiana, salvando solo alcune grandi compagnie dialettali, come quelle di Eduardo De Filippo, Gilberto Govi a Genova e Goldoni a Venezia», racconta lo scrittore che, proprio attraverso l’uso del dialetto siciliano – integrato in modo unico e originale nelle sue opere – ha dato un contributo fondamentale alla grande letteratura italiana. «I dialetti servono a rinvigorire continuamente l’albero della lingua nazionale: ne sono la linfa vitale». Lo stile narrativo del Maestro nasce da un’esperienza pratica, come egli stesso ricordava spesso: prima ancora che letteraria, è stata un’esperienza di ascolto e osservazione. Da giovane, sentiva parlare la piccola borghesia siciliana tanto in dialetto – per i discorsi più intimi, familiari, quotidiani – quanto in italiano, quando era necessario prendere le distanze, formalizzare, sottolineare una certa situazione. «L’italiano era, dunque, una lingua tra il notarile, il poliziesco e l’intimidatorio, mentre il dialetto era il regno delle affezioni e dei sentimenti». In questa visione è evidente l’influenza di un altro grande della letteratura, Luigi Pirandello, al quale lo scrittore ha più volte dichiarato di ispirarsi. Pirandello, in un saggio di fine Ottocento, scriveva: «Di una data cosa la lingua ne esprime il concetto, mentre della medesima cosa il dialetto ne esprime il sentimento». Per lo scrittore, dunque, il dialetto non è soltanto uno strumento di comunicazione, ma un mezzo indispensabile per esprimere emozioni profonde, viscerali. È proprio da questa esigenza espressiva che nasce una lingua ibrida – il sicitalianese – con la quale riesce a rappresentare la complessità della sua visione del mondo.