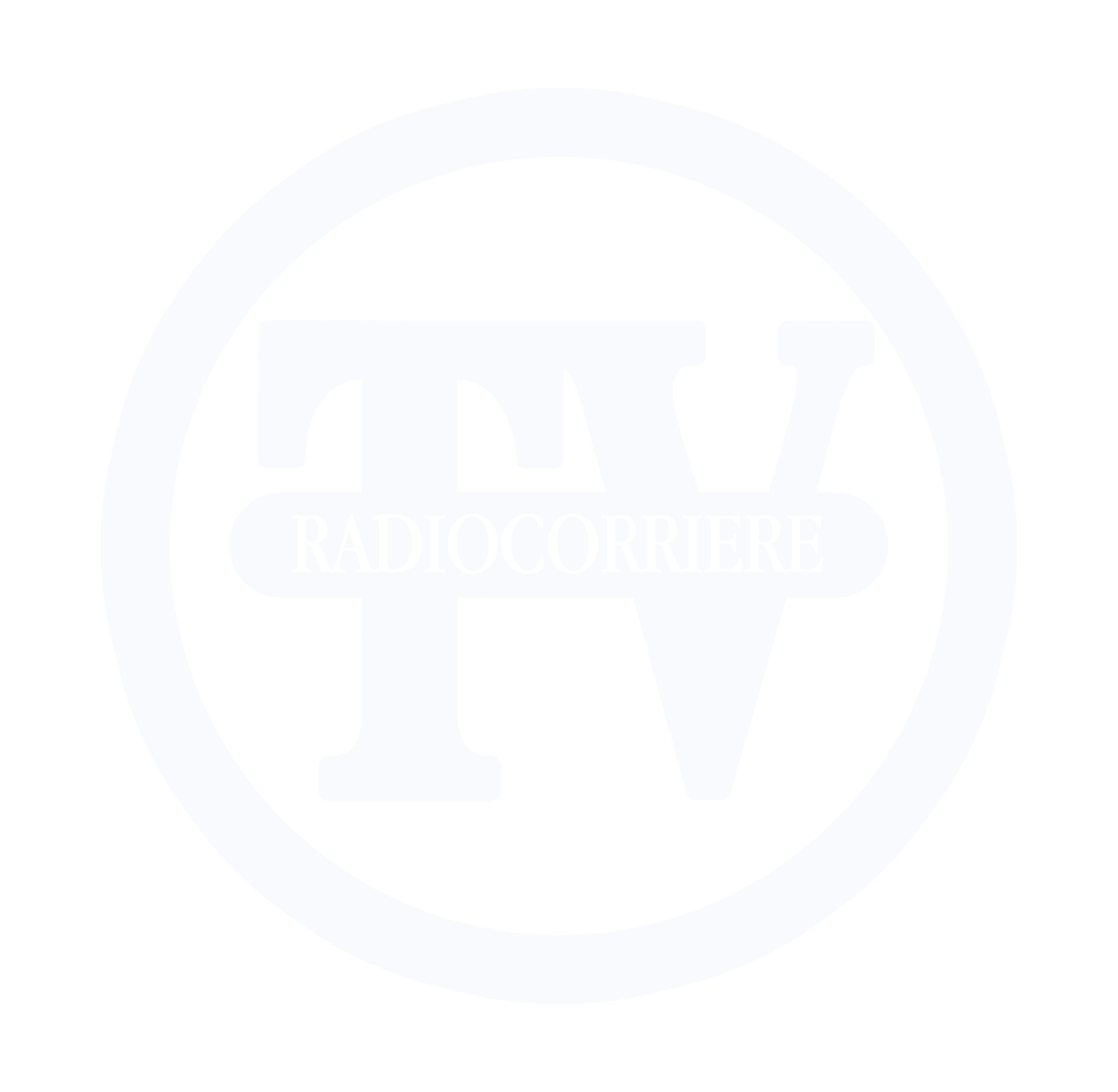Domenico Iannacone
Resistenza e speranza
Al via la nuova stagione di “Che ci faccio qui”, un viaggio profondo e intimo, raccontato al Radiocorrieretv dal conduttore: «Questa volta è un viaggio più profondo, più intimo. Se dovessi individuare una differenza rispetto alle stagioni precedenti, direi che c’è un’esplorazione dell’interiorità». Un viaggio nell’anima dell’Italia contemporanea, tra fragilità, resistenza e speranza. Da martedì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3
Si affronta il tema della perdita della memoria, una delle condizioni più laceranti che possa colpire l’essere umano. L’Alzheimer e le demenze cancellano i volti, smarriscono i legami, dissolvono l’identità. Domenico Iannacone raccoglie le storie che nascono all’interno del Centro Diurno Ra.Gi. di Catanzaro, fondato da Elena Sodano, dove si sperimenta una forma di cura che non si limita all’assistenza, ma cerca, attraverso la relazione e l’ascolto, di restituire dignità anche quando il tempo sembra aver smarrito il suo senso. Accanto a questo racconto si intreccia la storia di Pino Astuto, rinchiuso a soli otto anni nell’ex manicomio di Girifalco, dove ha trascorso trentadue anni della sua vita, pur non avendo mai ricevuto alcuna diagnosi psichiatrica. Una reclusione ingiusta che avrebbe potuto spegnere ogni ricordo, ogni traccia di sé. E invece, Pino ha custodito la propria memoria come un atto di resistenza silenziosa. Oggi, la sua testimonianza diventa voce necessaria: perché la mente, anche quando sopravvive segregata e sola, può essere l’unico rifugio per resistere all’ingiustizia.
Con uno sguardo empatico e mai giudicante, “Che ci faccio qui” continua a restituire voce agli invisibili, facendo della televisione un luogo di riflessione e coscienza civile.
Domenico, è arrivato il momento di rimettersi in viaggio…
Questa volta è un viaggio più profondo, più intimo. Se dovessi individuare una differenza rispetto alle stagioni precedenti, direi che c’è un’esplorazione dell’interiorità. Partiamo con “Ricordati di me”, due puntate dedicate alla mente, alla memoria, a ciò che è invisibile e spesso insondabile. Questo mi ha permesso di attraversare mondi che tendiamo a ignorare, che non guardiamo con attenzione. Nel primo capitolo raccontiamo la storia di una mente che si spegne con la malattia dell’Alzheimer. Siamo andata a Catanzaro, in un territorio complicato in cui l’associazione gestita da Elena Sodano rappresenta una forma di resistenza, offrendo una cura diversa della malattia, tarata sull’individuo, non massificata. Ogni persona che entra in quel luogo viene accolta per ciò che è, con le proprie peculiarità, perché l’Alzheimer non si manifesta mai allo stesso modo. L’approccio è cucito addosso a ciascun individuo, e proprio per questo è così umano. Continuiamo con la storia di una mente rimasta segregata per trentasei anni all’interno dell’ex manicomio di Girifalco, sempre in provincia di Catanzaro. È la vicenda di Pino Astuto, un uomo rinchiuso ingiustamente da bambino, quando aveva appena otto anni, con una diagnosi di “carenza affettiva”, una motivazione che oggi farebbe rabbrividire. Non aveva alcuna patologia psichiatrica, eppure è stato internato per una vita intera. È una delle tante ingiustizie inflitte silenziosamente, senza possibilità di ribellione. Eppure, la mente di Pino ha resistito a quella tortura, e oggi Pino testimonia con lucidità ciò che ha vissuto, del modo in cui la sua mente sia riuscita, nonostante tutto, a sopravvivere, per non cedere alla brutalità della segregazione. Il suo è un racconto potente, che ci ricorda quanto la mente possa essere un baluardo di resistenza, anche nelle condizioni più estreme.
La seconda puntata, invece, dove ci porta?
Continuiamo a lavorare sul tema della mente, racconto un trittico di storie. La prima è quella di Carlo Di Bartolomeo, un ragazzo autistico dotato di una mente sorprendente, che conosce profondamente testi di teatro, lavora con la compagnia Stato Patologico accanto ad altri attori con disabilità. È un pozzo di conoscenza, gli si può chiedere qualunque cosa e lui sa rispondere, dimostrando come, anche una fragilità può essere prodigiosa. Poi c’è la storia della cave multisensoriale del Policlinico Gemelli di Roma, una struttura dove si lavora per far emergere dal coma persone attraverso la somministrazione di immagini, di suoni, di odori, perché anche una mente apparentemente spenta può avere ancora un filo con il mondo. Infine, racconto la storia di un uomo che a 76 anni sta conseguendo la sua dodicesima laurea, una mente, quindi, che non ha mai smesso di essere curiosa, di imparare.
La terza…
Si chiama “La casa degli altri” e considera la casa non come elemento simbolico, fisico, bensì astratto. Protagoniste sono due storie molto intense, quella di Guglielmo, che avevo conosciuto otto anni fa e che aveva perso tutto, una persona che ho incontrato otto anni fa, che aveva perso tutto e che ho voluto raccontare di nuovo per capire se fosse cambiato qualcosa, dopo averlo messo in connessione con un’associazione, per arginare la caduta. La seconda è dedicata a Nikita, una badante romena che fa la scrittrice. Mi ha raccontato l’incapacità di avere una collocazione fisica, di avere una casa, di non sentirsi a casa in nessun posto. Questo rappresenta un elemento di straniamento molto toccante, che fa comprendere esattamente il significato della parola sradicamento, identità, accoglienza o sentirsi in qualche modo parte di qualche cosa.
La quarta…
“Parlami di te” è un ritorno a “Capra Libera”, vicino Nerola, un luogo già protagonista di un nostro racconto di cinque anni fa, che dopo quella puntata, ha fatto esplodere l’associazione. La visibilità ottenuta in tv ha portato a ricevere in comodato d’uso circa 500 ettari di terreno dai Comuni limitrofi, un riconoscimento importante del valore del loro lavoro. Massimo Manni, che gestisce questo santuario per animali, è un allevatore “pentito”, si prende cura oggi di circa 500 animali di ogni specie, che vivono liberi in un luogo straordinario. Tra loro ci sono anche animali con disabilità, che sarebbero condannati a essere abbattuti. La scelta di Massimo è rara e preziosa, perché dà dignità a vite che altrove verrebbero considerate inutili. Il suo è un gesto di profonda compassione, che restituisce senso e bellezza alla relazione tra uomo e animale. Una realtà davvero toccante e fuori dal comune. Accanto a questa storia, si sviluppa un altro filo narrativo: il rapporto dell’uomo con gli animali, con la natura. Al centro c’è un ex falegname, liutaio, fabbro – Guidalberto Bormolini – oggi sacerdote che insegna tanatologia, accompagnando le persone nel tratto finale della vita. Si occupa della cura spirituale delle persone in un percorso profondamente umano e compassionevole. È una puntata che, partendo dal mondo animale, arriva a toccare l’anima degli uomini, intrecciando storie personali, cura degli spazi e trasformazione. Guidalberto e il suo gruppo hanno anche ristrutturato un luogo nei pressi di Prato, un tempo abbandonato, che oggi accoglie persone che affrontano gli ultimi momenti della loro esistenza. Qui possono arrivare anche le famiglie, per condividere insieme questo tempo prezioso, in modo dignitoso e consapevole. In quel luogo, la morte non è vista come un’uscita marginale, ma come un passaggio che può ancora avere un senso profondo, un momento di riconnessione intensa con la vita. È una puntata molto intensa, che ci parla di spiritualità, cura e rinascita, anche laddove tutto sembra finire.
Queste storie sono abitate da protagonisti, ma anche da chi sta loro accanto: familiari, operatori, volontari…
Il nostro è sempre un racconto collettivo, non solo ai soggetti che offrono la loro testimonianza, appartiene anche alla famiglia, alla comunità. Io credo, in questi anni, di aver fatto attraversamenti che hanno a che fare con i bisogni collettivi del nostro tempo, ogni piccola storia diventa, così, un archetipo di quello che la società in qualche modo mi sta chiedendo.
Cosa racconta di noi italiani come popolo il programma?
“Che ci faccio qui”, così come “I dieci comandamenti”, sono programmi che non hanno mai subito contaminazioni, non hanno mai ceduto al populismo o alla manipolazione di suggestioni. Ho cercato di fare fotografie nitide, oneste. Credo che questo lavoro sia una sorta di cartina tornasole, uno specchio di noi stessi: chi guarda può ritrovare i propri limiti, le proprie debolezze ed errori, ma anche le speranze. Il mio obiettivo è restituire al telespettatore la sensazione di essere rappresentato davvero.
Hai mai provato a mettere te stesso di fronte lo specchio? Cosa resta dopo il viaggio?
Dopo ogni puntata, ogni stagione, ogni incontro ne esco trasfigurato, non sono mai lo stesso del giorno prima, è un’immersione profonda che non mi lascia indifferente, che non mi fa stare al margine. Le relazioni che creo con i protagonisti, con i luoghi, con le storie non finiscono con la puntata, restano. È come un treno che aggiunge vagoni a ogni viaggio, creando un esercito infinito di uomini e donne che rimangono ancorate alla mia esistenza, spesso gran parte del lavoro comincia dopo la messa in onda. Si crea una rete, una forma di solidarietà molto forte, i telespettatori dei miei programmi hanno costruito una sorta di comunità in cui si ritrovano e in cui sono pronti a dare una mano.
Anche il tuo è un lavoro collettivo. Come scegli i tuoi collaboratori?
Chi lavora con me deve condividere un progetto, deve immedesimarsi in una modalità narrativa un po’ anomala. Nei nostri racconti abbiamo reintrodotto le pause, abbiamo creato uno spazio riflessivo. Abbiamo una redazione molto piccola, da due anni lavora con me Gabriella Quartulli, condividiamo ogni parte del processo, dalle riprese al montaggio. Chi entra in un programma del genere non può rimanere distante, deve immergersi completamente. Le persone non devono avvicinarsi al racconto soltanto con la curiosità. Io dico sempre che le storie devono avere un reagente morale, devono avere un peso, un senso, un’etica.
A proposito di storie…
Abbiamo ormai assunto un atteggiamento verso le cose, verso gli altri che è dettato dalla fretta, mentre a me interessa che le storie vengano raccontate con il giusto tempo. La televisione non deve essere fagocitata, non deve lasciarsi avvolgere dal vortice imposto dalla velocità, per esempio dei social, ma deve rimanere se stessa, deve mantenere gli stessi canoni espressivi del cinema: immagini, i dialoghi e anche le pause. Tutto questo io non lo voglio perdere, anche a costo di andare controcorrente.
Il tuo è un giornalistico, ma anche un atto di osservazione sociologica. Come mantieni l’equilibrio?
In questi hanno ho imparato a esserci pienamente, essere un testimone nelle storie, mai protagonista, però, cercando di creare un racconto partecipante. Questo è un meccanismo mutuato dalla sociologia, per cui, chi entra per raccontare qualcosa, ha un punto di osservazione privilegiato, ma non deve sovrastare, entra nella narrazione in punta di piedi, con rispetto, cammina a fianco dei protagonisti. Sono gli occhi del telespettatore, guardo, mi immedesimo, racconto ciò che vedo senza alterarlo.
“Che ci faccio qui?” ha raggiunto anche il teatro…
Il teatro è diventato parte di questo bellissimo percorso, mi ha permesso di rinsaldare il legame con il pubblico, con quella comunità che attende la nuova stagione del programma, ma soprattutto ha rotto la quarta parete, facendomi uscire dal virtuale per entrare in contatto fisico con le persone. Se in tv parlo pochissimo, a teatro prendo la parola, divento parte attiva del racconto, compensando quello che il piccolo schermo non riesce a descrivere. Sul palcoscenico è come se riuscissi a entrare ancora di più nelle pieghe delle storie, un esperimento che mi ha restituito forza, energia, uno sguardo ancora più attento.
Ti senti una persona soddisfatta?
Soddisfatto è una parola difficile. Io sono un perfezionista, un professionista molto esigente, che cura con attenzione maniacale ogni dettaglio del lavoro, dalla scelta delle storie al montaggio. E questo significa che trovo sempre qualcosa da migliorare, soprattutto quando il livello è alto. Però sì, sono soddisfatto come persona, perché in tutti questi anni non mi sono mai dovuto piegato a logiche che non condividevo, ho potuto esprimere liberamente il mio pensiero. E in questi tempi, questo è già un grande privilegio.