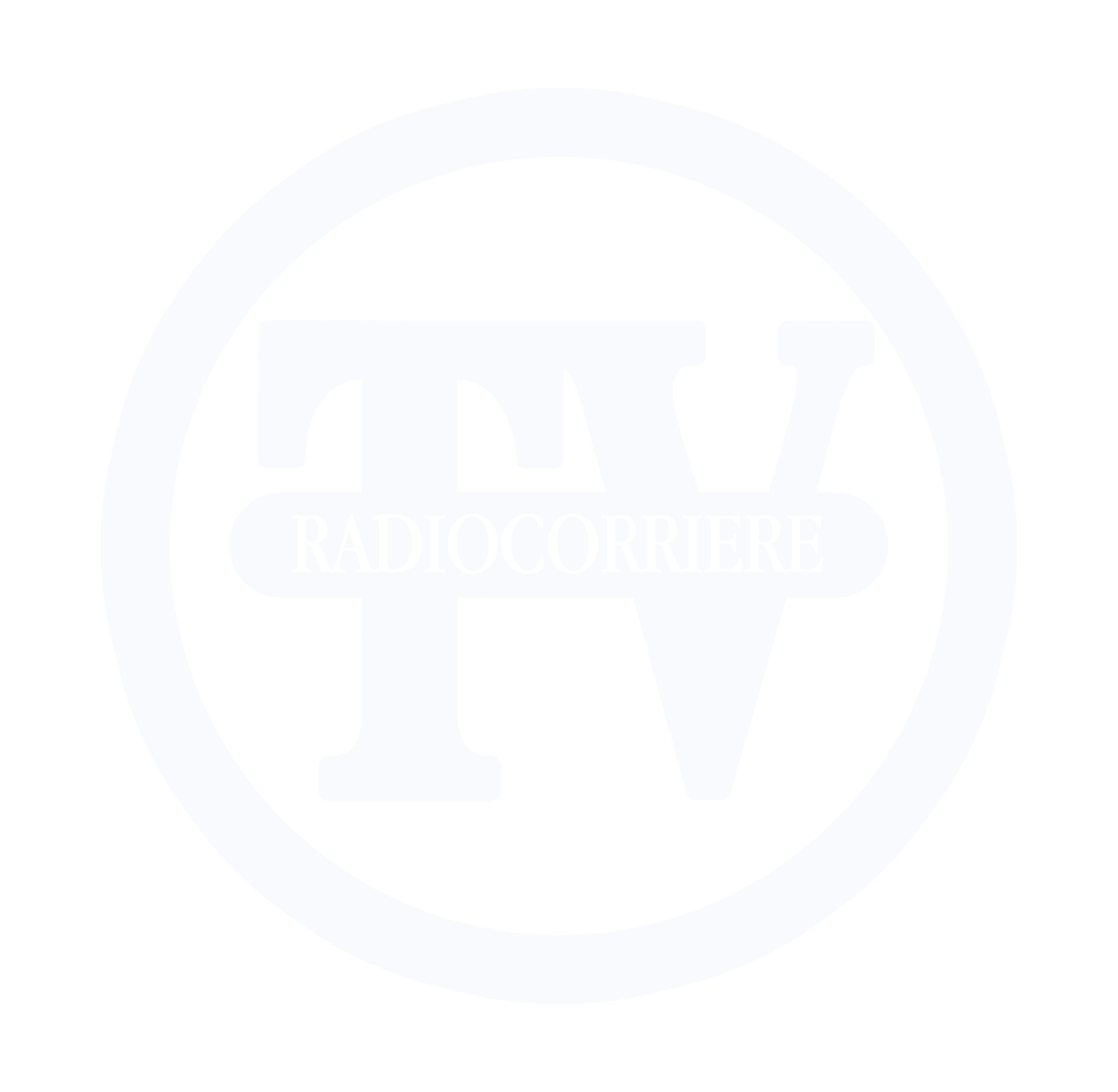Giulio Scarpati
Le Stanze di Verdi
Un viaggio cinematografico tra musica, storia e curiosità. Road movie alla scoperta di un Giuseppe Verdi inedito: agronomo, filantropo e patriota. Dal 6 ottobre al cinema, il film mescola docufilm e fiction, tra melodie verdiane, i luoghi storici di Busseto, le Roncole e Milano, e racconta il Maestro in una prospettiva emozionante e coinvolgente
Com’è nata la tua partecipazione a questo progetto e che cosa l’ha colpita di più durante le riprese?
Avevo lavorato tanti anni fa in un bellissimo film con Giorgio Leopardi, “La casa bruciata”, con le musiche di Ennio Morricone. Era la storia di un prete comboniano che difendeva gli indios, e che poi è stato ucciso. Il film era ispirato a quella vicenda, con la regia di Massimo Spano. Conoscevo il produttore e mi ha proposto questa nuova idea che mi ha un po’ spiazzato: un docufilm in cui dovevo interpretare me stesso, in una sorta di road movie nel Piacentino, fino a Busseto, le Roncole e Milano, attraversando i luoghi verdiani. Mi incuriosiva l’idea di essere allo stesso tempo spettatore e narratore della storia. Amo la musica e l’opera, quindi ero già avvantaggiato e subito attratto dal progetto.
Il suo personaggio si muove tra realtà e finzione…
Insieme agli sceneggiatori abbiamo pensato che mi trovassi a Piacenza per uno spettacolo, e che un imprevisto tecnico mi costringesse a restare lì. Da quel momento comincia il viaggio tra i luoghi verdiani, che è diventato anche un viaggio interiore. Il docufilm è molto onirico, con parti di fiction e molte improvvisazioni, nate dagli incontri reali con studiosi e persone legate alla figura di Verdi. Per me è stato un percorso nuovo, emozionante e pieno di curiosità. Il regista è Riccardo Marchesini, la supervisione è di Pupi Avati, con cui avevo già lavorato. E naturalmente ci sono le musiche di Verdi, dal vivo e di sottofondo, con un coro stupendo registrato in una chiesa.
Che tipo di emozioni ha provato in questo viaggio?
Molti di quei luoghi sono purtroppo in abbandono, e questo è un dolore forte. Ci sono città ricche che potrebbero fare di più per valorizzarli. Manca spesso la cura per le nostre meraviglie artistiche, e questo è un discorso generale per tutta l’Italia. Ma c’è anche l’altra faccia della scoperta: il rapporto tra Verdi e la sua terra. Era un agronomo, un allevatore, faceva formaggio, e reinvestiva i guadagni della musica nell’acquisto di terreni. Si alzava alle cinque per andare a cavallo e controllare i campi. Aveva una grande attenzione per i contadini e arrivò perfino a costruire un ospedale per loro, perché spesso morivano prima di raggiungere quello più vicino. È un aspetto poco conosciuto che mi ha molto colpito.
Nel docufilm emerge proprio un Verdi inedito. Quale di questi aspetti l’ha sorpreso di più?
Sicuramente quello dell’agronomo. Non lo immaginavo così attento ai dettagli pratici. Quando ha costruito l’ospedale per i contadini, ha cercato la massima eccellenza in ogni cosa, dalle attrezzature alle lenzuola, comprate personalmente. Lo stesso vale per la “Casa di Riposo per Musicisti” a Milano: l’ha progettata come un teatro, per far sentire a casa propria i cantanti e i musicisti in difficoltà. Essere benefattore per Verdi non era solo costruire, ma creare luoghi capaci di trasmettere dignità e bellezza.
E poi c’è il Verdi “popolare”, quello che ha avvicinato la musica alla gente…
Verdi ha fatto un’opera culturale enorme. Le sue arie si cantavano per strada: un modo per sentirsi parte di un’Italia che stava nascendo. In un Paese ancora diviso, la sua musica univa. E questo vale ancora oggi: ci insegna che l’arte può diventare linguaggio comune.
Dopo questo viaggio così profondo, cosa pensa possa insegnarci oggi la storia di Verdi?
Le sue difficoltà iniziali sono una lezione per i giovani che vogliono fare un mestiere artistico. Al Conservatorio di Milano lo bocciarono perché “inadeguato alla musica”. Ma non si arrese: trovò un maestro privato grazie ai suoi mecenati e andò avanti con determinazione. Ha trasformato il dolore, la perdita dei figli e della moglie, in creatività. Verdi è diretto, sincero, parla con la forza della terra: entra subito nei sentimenti. E questo lo rende universale.
Qual è il luogo verdiano che l’ha emozionata di più?
La suite dove Verdi è morto. C’è ancora un rispetto tangibile: mettono la paglia per strada per attutire i rumori, come fecero nei suoi ultimi giorni. È un segno di attenzione, di memoria viva. E credo che sia giusto ricordare Verdi non solo come un musicista straordinario, ma come un uomo che ha reso popolare l’opera.
Nella sua carriera ha interpretato spesso figure legate alla memoria e all’identità italiana. Questo l’ha aiutata ad entrare nel mondo di Verdi?
Forse sì, ma in modo diverso. Quando interpreti una persona realmente esistita hai la responsabilità di essere credibile. Con Verdi è stato più libero: non lo interpretavo, lo cercavo. Mi piaceva scoprire l’uomo dietro il mito. Spesso semplifichiamo troppo queste figure. Vale anche per Pascoli, a cui sto dedicando ora uno spettacolo teatrale. Anche lui è stato ridotto a poche poesie scolastiche, ma era un poeta modernissimo, pieno di curiosità e umanità. Raccontare figure così, restituendo loro complessità, è un modo per fare giustizia alla cultura italiana.
E per concludere, lasciamo Verdi ed entriamo in “Cuori 3”. So che ci sarà una bella novità…
Sì! Interpreto Gregorio Fois, un sensitivo che entra nell’ospedale delle Molinette come nuovo primario. È un personaggio molto intuitivo, elegante, ma anche un po’ stravagante. In ospedale crea scompiglio: non gli va mai bene nulla, vuole fare a modo suo! È stata un’esperienza divertente, in un clima sereno e creativo.