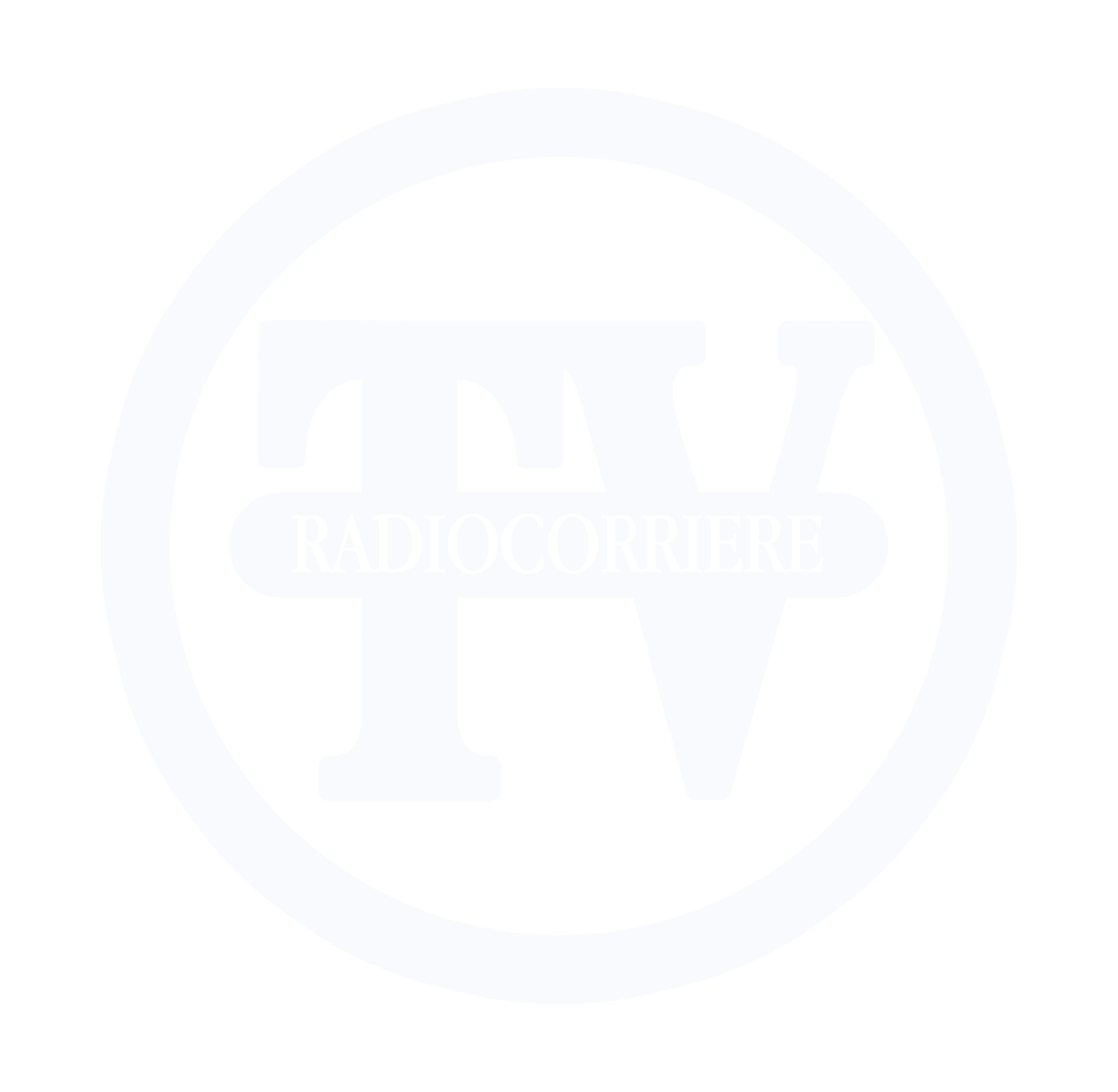Onde ribelli – 50 anni di libertà in FM
Cinquant’anni fa, in Italia, le radio libere accendevano le frequenze dell’FM con la forza della passione, della disobbedienza creativa e del desiderio di raccontare il mondo fuori dai canali ufficiali. A celebrare quella rivoluzione è il docu-racconto in onda venerdì 2 maggio alle 16.15 su Rai 3, scritto e diretto da Maurizio Pizzuto. Un viaggio sonoro tra voci storiche, sogni collettivi e nuove prospettive. Ne parliamo proprio con l’autore e regista, per scoprire cosa resta e cosa ancora pulsa di quella straordinaria stagione di libertà
Dove nasce l’idea di raccontare la storia delle radio libere in Italia?
L’idea nasce da una passione personale e da un’urgenza storica. Da tempo sentivo che la storia delle radio libere, che hanno segnato una rivoluzione culturale e sociale in Italia, meritasse di essere raccontata con profondità. È un progetto che ho avuto a lungo nel cassetto, ma è maturato nel tempo, ascoltando voci, raccogliendo memorie, sentendo il bisogno di restituire quel patrimonio alle nuove generazioni. Raccontare le radio libere significa parlare di libertà, di creatività e di sogni collettivi: valori che non invecchiano mai. Poi, insieme con Pino Nano, con il quale abbiamo scritto il soggetto e la sceneggiatura, abbiamo cercato di condensare 50 anni della storia delle radio libere in un racconto che fosse coinvolgente, accessibile, ma anche rispettoso della complessità e della varietà di quella stagione straordinaria. È stato un viaggio nella memoria collettiva, e allo stesso tempo un gesto d’amore verso un’epoca che ha ancora molto da insegnarci. E farlo nel pieno del centenario della radio ha dato al progetto un significato ancora più forte: è diventata l’occasione per riflettere non solo sul passato, ma anche sul presente e sul futuro di un mezzo che, nonostante tutto, continua a pulsare di vita propria.
“Onde Ribelli” è un titolo potente. Cosa rappresentano oggi per lei quelle onde, e perché le definisce “ribelli”?
Quelle onde sono ribelli perché hanno infranto il silenzio imposto, hanno violato – in senso buono – l’etere monopolizzato, dando voce a chi non ne aveva. Ribelli perché libere, indipendenti, creative, improvvisate eppure vitali. Oggi, quelle onde rappresentano ancora una scintilla di autonomia e di espressione genuina: un modo di comunicare senza filtri, senza padroni. E in un’epoca in cui tutto è iper-controllato e mediato dagli algoritmi, quella ribellione suona più attuale che mai.
Nel documentario c’è un mix affascinante di testimonianze, immagini d’archivio, voci celebri e meno note. Com’è stato il lavoro di ricerca e selezione dei materiali?
È stato un lavoro lungo, appassionante e a tratti commovente. Abbiamo scavato negli archivi pubblici e privati, in vecchie cassette, fotografie, fanzine, volantini. Ogni ritaglio aveva una storia da raccontare. E poi le testimonianze: abbiamo cercato di dare spazio a voci famose, certo, ma anche a chi ha vissuto quella stagione con la stessa intensità, magari in una piccola radio di provincia. L’equilibrio tra noto e ignoto era fondamentale per restituire la coralità di quell’epoca.
Tra le tante voci del documentario c’è anche quella di Vasco Rossi, che racconta i suoi esordi. C’è un’intervista o un aneddoto che l’ha particolarmente colpita durante le riprese?
Sì, ce ne sono stati molti, ma uno degli aneddoti più sorprendenti è proprio quello raccontato da Vasco Rossi, quando rivela che, ancora ragazzo, con gli amici aveva costruito un piccolo trasmettitore artigianale per ascoltare i dischi che non si sentivano in radio. Trasmettevano dalla cucina e poi scendevano nell’aia ad ascoltare la musica con il sole in faccia. È un’immagine semplice ma potentissima, che racchiude lo spirito pionieristico e la libertà creativa delle radio libere. Quell’episodio mi ha colpito per la sua autenticità: c’era passione, ingegno e il desiderio di rompere il silenzio imposto dalla programmazione ufficiale. Un piccolo gesto che preannunciava una grande rivoluzione.
Che eredità ci ha lasciato oggi quel fermento delle radio degli anni ’70?
Ci ha lasciato il coraggio di provare, di dire, di sperimentare. Ci ha lasciato la consapevolezza che i media possono nascere dal basso, che la comunicazione non deve per forza passare dai grandi gruppi. E ci ha lasciato anche un’idea diversa di comunità: quella costruita con le voci, con la musica, con le parole scambiate in diretta. Un’eredità invisibile ma fortissima.
Nel documentario si parla anche del futuro della radio. Qual è il suo punto di vista sul ruolo dell’FM oggi, tra podcast, streaming e algoritmi?
L’FM oggi è un atto quasi poetico. Ha perso centralità ma non significato. È un linguaggio che resiste, e proprio per questo diventa più prezioso. Mentre podcast e streaming sono on demand, l’FM è “qui e ora”, come un abbraccio in tempo reale. Gli algoritmi ci dicono cosa ascoltare; la radio libera, invece, è una sorpresa. E noi abbiamo bisogno ancora di essere sorpresi.
Ha vissuto in prima persona la stagione delle radio libere? Che ricordi ha di quel tempo?
Sì, l’ho vissuta, sebbene da giovanissimo ascoltatore. Ricordo la magia di sentire una voce amica nella notte, il piacere della scoperta, le cassette registrate dalla radio, le dediche. Era un mondo vivo, imperfetto, ma pieno di umanità. Era come entrare in un salotto condiviso, senza bisogno di inviti. E col tempo, anche io mi sono cimentato davanti a un microfono: un’esperienza intensa e formativa, che mi ha fatto apprezzare ancora di più quel linguaggio diretto e intimo.
Se potesse mandare oggi un messaggio in FM, come si faceva una volta, cosa direbbe agli ascoltatori e alle ascoltatrici del 2025?
Direi: “Restate liberi, restate curiosi. Le frequenze del cuore non le può sintonizzare nessun algoritmo. Accendete la radio, fate silenzio, e ascoltate: c’è ancora qualcuno che parla davvero con voi.